IL MEDIOEVO PRESENTE
- Gilberto

- 6 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Come combattere le differenze economiche
“Verso il 1300 a Saint Omer si censiscono 10 cavalieri, 300 ricchi, 300 possidenti, 10mila capifamiglia di cui 3mila poveri” (da L'uomo Medievale a cura di Le Goff, edizioni Laterza),
La società medievale così rappresentata definisce al suo interno, su un totale di 10mila famiglie, un 30% di popolazione povera contro un 5% di popolazione benestante.
Parimenti potremmo ragionare in termini di disponibilità della ricchezza, in cui al 5% della popolazione benestante spetterebbe certamente una ampia maggioranza dei capitali complessivi mentre al 30% dei poveri non resterebbero che gli abiti che indossano e poco più.
La sperequazione, la distanza siderale tra la ricchezza e la povertà, quella che oggi definiamo come mancanza etica nella redistribuzione economica sono figlie dell'Umanità, assai più che del nostro tempo, e nel particolare sono figlie di quell'economia tipicamente umana che definisce il censo, l'onorabilità e la rispettabilità in funzione di se stessa, indipendentemente dalle qualità individuali o da quel diritto naturale oggi fortemente invocato.
Da che l'umanità inventò la moneta e con la moneta l'accaparramento e l'avidità, la distanza tra ricchi e poveri, tra potenti e subordinati, è stata marcata e la struttura sociale, rileggendo i testi di storia medievale, perfettamente sovrapponibile a quella contemporanea.
Nulla di nuovo sotto i sole, neppure sotto il profilo delle contestazioni e delle rivolte.
Alle condizioni di lavoro sottopagate si ribellavano i servi della gleba così come gli operai (famosissima la rivolta dei Ciompi a Siena e Firenze, sorta di sciopero generale odierno), mentre si diffondevano eresie pauperiste a contrastare l'opulenza curiale e a dedicarsi al brigantaggio intercettando ricchi mercanti in spazi isolati e boschivi. San Francesco, si dice, ammansiva i “lupi”, com'erano detti i briganti d'allora e parlava con gli “uccellini”, com'erano definite le torme di bambini cenciosi che si nutrivano di ciò che trovavano.
Fra Dolcino esaltava le piazze straccione e la Curia lo poneva sul rogo dopo inenarrabili sevizie.
Intanto nasceva MontePaschi, che deve il nome ai pascoli comuni che il monte poneva all'asta in affitto ai pecorai, quei pecorai che fecero con le loro lane la successiva fortuna dei Medici tessitori, famiglia la cui vicenda economica ricorda da vicino quella, per esempio, dei Benetton contemporanei.
Se nulla di nuovo o di diverso accade nelle società umane nel corso dei secoli è forse perché nulla di nuovo è subentrato nella dinamica economica.
Se la diversità tra ricco e povero grida allo scandalo per chi ancora dispone di un'etica o di morale è perché la modalità dell'economia è identica a se stessa.
Da un lato la struttura dell'avidità e dell'accaparramento di ricchezze, dall'altro formule anacoretiche di privazione e spossesso, di rinuncia e sobrietà che da millanta anni si rincorrono senza scalfire il corpo sociale, creando al più santi e illuminati a cui guardare con stima e incomprensione.
Bramini e buddisti, fraticelli, filosofi e figli dei fiori esortano alla ricerca interiore e al rifiuto di un consumismo che si traduce in narcisismo coatto, ma troppo forte è la voce del capitale, troppo prepotente quella della propaganda, troppo irruente la dinamica dell'economia per pensare di poterle spezzare.
Vale allora il tempo e la pena di valutare se noi si sia figli della nostra natura o dell'educazione impartita dal modello prevalente. Se la smania dell'acquisto, della spesa e dell'apparenza sia implicita nell'umano o non piuttosto appresa dai canoni economici. E nel caso in cui la risposta sia d'apprendimento vale ancor di più il tempo e la spesa di cercare alternative, soluzioni etiche e morali, eque e distributive. Un'azione immediatamente possibile è l'agire selettivo dell'acquisto, premiando la circolarità e il riutilizzo, rintuzzando la formazione del capitale dal capitale usando le sue stesse armi di consumo, sostenendo chi imprende con equità e rispetto.
La rivoluzione è certo lontana ma ancora la ribellione è possibile, persino doverosa.
Consumare meno, consumare il necessario e consumare selettivamente sono le armi disponibili.
Il resto è doverosa teoria.




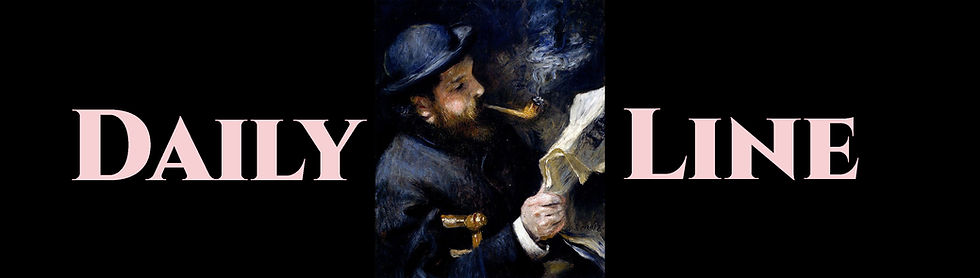
Commenti